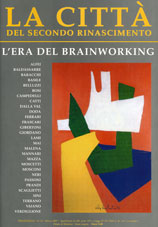Numero 23 - L'era del brainworking
Carlo Sini
docente di Filosofia teoretica all'Università Statale di Milano, membro dell'Institut International de Philosophie di Parigi
LA MERCE E LA FESTA
Quando si parla d’impresa, anche d’impresa intellettuale, si parla di produzione, di qualcosa che prima non c’era e poi c’è. Ma come si produce quello che comunemente si chiama merce? Che cos’è, innanzitutto, una merce e come può essere valutata sia in un ambito strettamente economico, sia in un ambito più ampiamente umano? La produzione, in particolare della merce, si annoda strettamente con il problema del tempo. Si ha merce in quanto si ha un geroglifico temporale o, per dir così, un’incarnazione temporale, un coagulo di tempo. Qualunque cosa sia stata prodotta esige tempo: il pensiero degli economisti classici ha sempre tenuto conto, in primis, del tempo della sua produzione. Se la merce è un coagulo di tempo, essa varrà tutto il tempo che è costato per produrla. Se devo produrre qualcosa, anzitutto ci vorrà tempo per procurare la materia prima: questo è il primo parametro che interviene a stabilire il valore della merce. Il secondo parametro è il tempo di lavoro per trasformare la materia prima in un oggetto. Ma poi c’è un terzo tempo, quello che occorre per distribuirla, per renderla disponibile laddove presumo che venga richiesta o laddove è richiesta. A questi parametri va aggiunto il valore di mercato, che non è strettamente dipendente dal lavoro impiegato nella produzione della merce, ma dal desiderio, dal bisogno del compratore.
L’economia classica considera la produzione esclusivamente come se l’economia dovesse sempre sopperire ai bisogni naturali, ma il concetto di naturale è molto vago. Proprio la produzione capitalistica, la rivoluzione moderna e la scienza moderna, producendo una quantità di beni che sono molto al di là del bisogno naturale e, quindi, un’offerta esuberante rispetto alla richiesta, hanno creato i presupposti e le condizioni per una trasformazione merceologica fondamentale, che si è messa in moto con i primi arricchimenti della società europea moderna e ha toccato il suo punto più alto negli anni sessanta del secolo scorso. In una società affluente, ricca di prodotti, il consumatore non ha bisogni, ma desideri, non acquista soltanto quantità di tempo, ma qualità di tempo. Che cosa significa per il compratore dire che la qualità è ciò che è richiesto al prodotto? Prendiamo un esempio: il rasoio di mio padre era un oggetto bellissimo, di acciaio, fatto in Germania, con una base di legno tutta lucidata, un oggetto di qualità. Però noi troviamo molto più funzionali quei rasoietti che si comprano al supermercato e si buttano via dopo una o due volte: non hanno bisogno delle cure richieste da quello di mio padre, ci fanno guadagnare una quantità di tempo infinita e quindi migliorano la qualità della nostra vita. La produzione fa cose che si buttano via e che in apparenza sono più brutte, ma sono cose che tendenzialmente fanno della nostra giornata un luogo di libertà. Allora, possiamo dire che la produzione classica di merci è la produzione di un avere, è produzione di tempo coagulato in averi, che costituiscono il fondamento materiale della nostra garanzia che i bisogni quotidiani saranno, in qualche misura, esauditi. La produzione che incomincia con la società moderna non dà luogo ad averi, ma a una nuova forma di essere. Dall’avere passiamo all’essere. Noi vediamo, infatti, decadere ampiamente i grandi patrimoni edilizi, i grandi patrimoni agricoli, tutti coloro che hanno avuto per generazioni le grandi ville stanno vendendole agli americani e ai calciatori, che ne fanno oggetto di esibizione. Perché? Perché non interessa più averle, perché quello che compriamo oggi, o vorremmo comprare, è la libertà di essere, non la quantità dell’avere. La libertà di essere come qualità del nostro tempo, come qualità della nostra vita, come libertà delle nostre azioni. Si potrebbe dire che stiamo passando dalla logica del profitto a un recupero moderno, assolutamente inedito e inaudito, della società della festa, della festa originaria.
La festa originaria era la celebrazione, per dir così, della liberazione dal bisogno una tantum. Una volta l’anno, c’era la grande festa, la grande dépense, lo sperpero: mangiare e bere a crepapelle, dare fondo alle provviste sul fare della primavera, che promette nuove messi e nuovi armenti, anche come gesto di fiducia verso gli dei: “Sperpero tutto perché ho fiducia in te, che mi aiuterai”. La festa era questo momento di totale distruzione di ciò che si era centellinato e messo da parte, come atto che univa una comunità, ma che insieme andava tenuto nei limiti dell’eccezionalità. Ebbene, noi stiamo andando verso una società che – proprio per la sua natura, la sua capacità di produrre una quantità sterminata di oggetti sostanzialmente inutili, se guardati sotto un profilo economico strettamente legato ai bisogni, ma estremamente importanti, se guardati invece alla luce del desiderio, del desiderio di essere, non di avere – entra nella logica della festa, che non vuol dire dello sperpero necessario, anche se lo sperpero c’è nelle nostre società ed è quasi inevitabile, perché se c’è ricchezza, c’è sperpero. Ecco perché dico che, nella produzione della merce, attualmente, c’è un’idea – anche se è soltanto un’idea – di festa. La merce è festosa, è festiva, è una festività profana, che ha lati positivi e negativi, si può esaminarla da tanti punti di vista, ma certamente è irrefrenabile. Chi volesse produrre oggi il rasoio di mio padre fallirebbe, non troverebbe altro che qualche nostalgico compratore, che poi lo metterebbe in una vetrina e non lo userebbe mai, perché gli farebbe perdere troppo tempo e quindi minaccerebbe la qualità della sua vita, del suo essere.
La gran parte delle merci che oggi progettiamo, costruiamo, offriamo, facciamo circolare per tutta la terra – al di là di quelle che rispondono ai bisogni fondamentali e che comunque si trovano anch’esse in una trasformazione profonda, buona o cattiva che sia – non soddisfano bisogni, ma offrono occasioni. È questo che i giovani delle province del Sud del nostro paese o di altri paesi extracomunitari cercano venendo da noi: occasioni. La merce oggi è tanto più desiderata, tanto più attraente perché essa non è la semplice risposta, un arco riflesso bisogno-soddisfazione, ma perché nella merce c’è una cosa in più, una cosa di più, che è l’occasione. Occasione che ha a che fare con il tempo, e non con il tempo quantitativamente misurato, ma con la qualità del tempo. Nessun giovane oggi desidera avere castelli o campi sterminati, si accontenterebbe di un appartamentino a New York e di un altro a Parigi. Cosa se ne fa della campagna? È in cerca di occasioni, di ciò che dà luogo a conseguenze. In questa trasformazione merceologica, dal profitto si passa alla festa, all’orgia, all’orgia primitiva rivisitata modernamente, e dall’accumulazione si passa alle possibilità.
Allora, siamo al punto per vedere bene ciò che la merce oggi ci dà: qualcosa che ha a che fare con l’arte, non nel senso estetico del termine, ma nel senso in cui ne parlava anche Armando Verdiglione, l’arte, l’artificio, la capacità tecnica, imprenditoriale, intellettuale di creare intorno alla merce una forma di vita, o meglio di fare della merce una forma di vita. E qui c’è un pensiero che va al di là di ciò che gli economisti ci hanno insegnato e che emerge esaminando alcuni fenomeni contemporanei molto interessanti, che prendono il nome di toyotismo. Che cos’era il toyotismo? Una trasformazione merceologica profonda, per cui la merce, la cosa materiale diventa una cosa più i servizi annessi. Il toyotismo è stata una rivoluzione grandiosa, ma quello che sta succedendo è qualcosa di ancora più grandioso: oggi, non ti do soltanto la cosa, che risponde al bisogno, più il servizio, che risponde a un desiderio, ti do qualcosa di più, un mondo, un’occasione, una cura di te. Non è casuale quella nota pubblicità che dice: “Perché voi valete”. È questa la merce nuova, la merce che non si limita a rispondere a un semplice desiderio, non risponde all’esigenza di sopravvivere, ma al desiderio di essere, di uscire dall’anonima fatica di vivere, di acquisire una qualità di esistenza, di essere qui, esistenti come valore incarnato. E, allora, per essere oggi all’altezza della sua produzione, della sua metafisica, per dir così, la merce deve offrire non soltanto i servizi, ma i piaceri, l’occasione del piacere nel suo evento. Non è casuale che ci sia in Italia questo trionfo – discutibile nella sostanza – della cultura nelle piazze, dei festival della letteratura, della filosofia, della scienza. I critici si chiedono quanta di questa massa di gente che vi partecipa davvero si avvicini alla scienza, alla letteratura e alla filosofia, ma di sicuro chi vi partecipa lo fa perché si sente, diversamente da prima, in un’atmosfera dove il piacere di essere e la qualità festiva del suo tempo sono nutriti. Questa è la stessa logica attraverso cui i giornali hanno fatto esperienze incredibili, riuscendo a vendere libri che gli editori non riuscivano proprio a vendere. Questo è un fenomeno che dice che la merce che m’interessa è quella che mi cambia la vita, che mi dà un’altra qualità di vita, che mi fa essere diversamente, non che mi fa avere. Niente di più cieco del capitalismo finanziario, che ancora si fonda sull’avidità dell’avere. Finché saremo legati a questo capitalismo, a questo liberismo, non riusciremo a decollare come società globale.
Quando capiremo che la merce denaro oggi è quella che deve circolare per offrire occasioni, in tutti i sensi della parola, e quindi per produrre non principi, non cose che si mettono alle spalle come fondamento, ma conseguenze? Se noi comprendiamo che la produzione di merce, oggi, è produzione di occasioni e che, solo attraverso l’occasione, la materialità della merce ci torna indietro con un suo plausibile valore, solo allora, cominciamo a comprendere in che mondo viviamo e come l’imprenditore debba stabilire un patto di alleanza con la cultura, perché soltanto attraverso la cultura possiamo dare, oltre al sollevamento dal bisogno, la qualità del tempo, la circostanzialità.
Oggi la società è fatta di mediatori, il mediatore è diventato fondamentale, fino ai livelli paradossali che ci vengono dagli Stati Uniti. Il mediatore diventa il tecnico, colui che spiega nell’azienda come ci si deve comportare con gli impiegati o con la dattilografa, perché il buon senso non basta più e l’educazione nemmeno, arriviamo alla follia americaneggiante. Però, questo significa che c’è bisogno della mediazione, del tempo come mediazione, del tempo come collocazione della merce in un tempo di qualità festiva, dove ciò che attrae il compratore, il fruitore è la qualità del tempo, cioè l’occasione per essere e potere dire “io ero lì”. Il successo delle grandi mostre nasce così. Rimaniamo stupefatti e ci chiediamo perché una mostra abbia migliaia di visitatori e lì accanto c’è un museo con grandi capolavori dell’arte in cui non entra nessuno. Perché? Perché quella merce non è stata esibita nel modo festivo della fruizione, non gli è stato dato quel valore aggiunto che è essere qualità di partecipazione, qualità di occasione, qualità di tempo, giornata di vita.
Allora, tutto questo si può riassumere in un’espressione: noi non assistiamo soltanto a una smaterializzazione della merce, che sempre più è trasformata in funzione e affrancata dalla sua materia – la funzione della lametta, del rasoio usa e getta –, non solo la funzione ha smaterializzato la merce, rendendola ultrasensibile e ponendola in un centro di relazioni impossibili, ma, soprattutto, l’ultima rivoluzione economico-industriale ha reso la merce uno spettacolo. Noi siamo di fronte a una spettacolarizzazione della merce. La merce deve essere spettacolare, altrimenti non è percepita come un valore, non è desiderata, non costituisce motivo di ricerca, di godimento, di partecipazione, di cura di sé. E la merce oggi per avere successo deve poter offrire l’occasione. Stanno fiorendo, per esempio, casi di librerie, dove si va anche a bere, a mangiare, a chiacchierare, dove si può prendere un libro, osservarlo e rimetterlo al suo posto. Luoghi di vita, luoghi che escono sempre di più dalla specializzazione per inglobare occasioni di vita insieme. Ecco l’invenzione qualitativa, ecco la possibilità, ogni volta, d’immaginare un’alternativa, che deve essere un’offerta di spectaculum.
Ora, è chiaro che la spettacolarizzazione è uno dei nostri problemi, uno dei nostri difetti e anche uno dei nostri rischi: che tutto si vanifichi nel mero spettacolo. Certo, non sto dicendo che tutto questo è buono, ma che tutto questo accade, e starà a noi prendere l’aspetto buono, corretto da quello cattivo. Quello che è certo è che i competenti in qualità della vita sono gli uomini di cultura, non solo perché frequentano la cultura, ma perché sono coloro che, da tempo immemorabile, hanno fatto la scelta del tempo festivo, non hanno pensato ad accumulare, ma alla qualità del loro tempo, per questo sono intellettuali, persone che hanno detto “Anch’io vorrei essere ricco, anch’io ho famiglia – come diceva Socrate ai suoi figli –, ma se penso a cosa mi costerebbe, preferisco essere molto meno ricco, o addirittura povero, ma avere libero il mio tempo o quanto più posso del mio tempo. Desidero essere e non avere”. Tutto ciò è antichissimo, possiamo ritrovarlo nelle prime figure degli stregoni, dei sacerdoti, dei monaci e l’erede di questa grande tradizione è colui che non ha mezzi, non ha forza, ma rappresenta il desiderio di tutti, incarna il desiderio di tutti. Ora, se questo desiderio diventa una parte cospicua della produzione, della civiltà, della civiltà delle merci, e quindi dell’incivilimento del consumatore, con tutti i rischi e pericoli, allora si capisce perché l’imprenditore debba essere un imprenditore intellettuale, debba dialogare con la cultura, entrare nella logica della cultura e dare non soltanto una cosa utile, una cosa che serve anche a lui per produrre profitto e andare avanti a produrla, ma una cosa che crea una qualità di vita migliore. Questa è la civiltà della produzione attuale. Che tutto questo sia, nel quadro generale, specifico dell’Italia mi sembra evidente. L’Italia non avrà mai la possibilità di competere con le fabbriche di Detroit. Non avrebbe nemmeno senso. Però, la cultura che ha l’Italia, la sua tradizione, la sua qualità di vita e il suo patrimonio di memorie, di cose, di costumi e di lingua, sono la vera ricchezza. Se i nostri imprenditori non capiscono questo, siamo perduti, se si mettono a imitare i modelli cretini degli americani, siamo perduti, perché quelli vanno bene per gli americani. In una grande impresa, fatta nel modo anglossassone, queste cose evidentemente funzionano,ma da noi sono ridicole e spesso nocive, soprattutto perché ci distraggono, ci mettono in una competizione, che è perduta in partenza e che non è l’anima della cosa, perché l’anima della cosa è gratuita. La cultura si offre, si dà. La merce, che non è gratuita, deve portare un’occasione di cultura, che non è gratuita nel senso che è aperta a tutti, ma nel senso che non può essere quantificata. Il tempo non può essere ridotto a quantità di tempo e quindi oggi si tratta di un’economia differente. Se poi pensiamo che siamo qui, in queste città, in questa regione che ha dato l’impulso iniziale al festival della letteratura, al festival della filosofia, c’è motivo di riflettere. Non so come si possano stabilire le connessioni, ma occorre l’avvio di un dialogo in cui ci si comprenda e si pensi insieme che cosa significa qualificare le merci di questa regione, di questo paese, di questa nazione, nel quadro generale. Questa è la nostra possibilità più propria, qui c’è un grande futuro, se sappiamo cogliere questa occasione e riflettere su che cosa vuole la gente, il pubblico mondiale oggi. E allora un dialogo tra la cultura e l’impresa mi sembra la cosa più concreta che possiamo immaginare, più urgente, più propriamente fruttuosa, se sapremo avviarlo in maniera stimolante.